SHOP
Basalt Queens -Sober Wine Monti Lessini 0,75cl
ORIGINE: Monte Crocetta a Terrossa di Roncà, zona nord della DOC di Soave, Monti Lessini.
VITIGNI: Garganega 60%, Durella 40%
DENOMINAZIONE: Indicazione Geografica Tipica – IGT
ANNATA: 2019
TIPOLOGIA DEL TERRENO: Vulcanico, argilla rossa e basalto
ALTITUDINE: 250-300 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE: Sud, sud ovest
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Pergola Veronese
METODO DI ALLEVAMENTO: Senza l’uso di prodotti chimici, con coadiuvanti naturali, inerbimento, basse rese
VENDEMMIA: Settembre
RACCOLTA: Manuale in cassetta
VINIFICAZIONE: Lieviti indigeni, affinato in cemento con l’assemblaggio delle due masse, senza additivi naturali o chimici
ALCOOL SVOLTO: 11,5% Vol.
ALLERGENI: Solfiti, naturalmente presenti
ESAME ORGANOLETTICO: Colore giallo paglierino, riflessi dorati. Al naso sentori minerali e agrumati.
In bocca secco, lungo con una bella persistenza, intrigante l’acidità
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10°C
IL PENSIERO DEL VIGNAIOLO
IL TAPPO STELVIN
Storia del tappo a vite
Le prime sporadiche apparizioni dei tappi a vite in ambito enologico risalgono alla seconda metà del XX secolo.
Prima di allora questa tipologia di chiusura era riservata ad altre bevande o era un rimedio domestico alla rottura del tappo in sughero: il winelover che non riusciva a risigillare la bevanda con il sughero, perché rotto o compromesso durante l’apertura della bottiglia, ricorreva a questo tappo.
Si trattava dunque di una soluzione di emergenza: all’epoca era praticamente impossibile immaginare una chiusura diversa da quella in sughero, che godeva di grande reputazione.
Del resto, per ogni altro materiale era difficile competere con il connubio di proprietà impermeabili ed elastiche caratteristiche di questo tappo.
Col tempo il sughero diventò una risorsa scarsamente disponibile o comunque non in grado di rispondere alla crescente domanda di tappi dovuta ad un incremento della produzione e della vendita di vino.
Già dagli anni ’70 furono studiate nuove alternative, soprattutto in quei Paesi dove l’approvvigionamento di sughero risultava difficoltoso. In alcune nazioni, come Australia e Stati Uniti, comparvero i primi tappi sintetici, ottenendo anche un discreto successo.
Nei Paesi europei con una spiccata cultura e tradizione vinicola i tappi a vite sono comparsi più tardi, verso la fine del XX secolo.
Qui i tappi a vite sono stati sempre associati a prodotti di scarsa qualità per cui si è affermata una dicotomia difficile da sradicare: tappo in sughero – vino di qualità, tappo a vite – vino di basso livello.
E come per ogni convinzione ci sono voluti anni e anni prima di metterla in discussione.
Oggi molti produttori si sono accorti delle potenzialità di questa chiusura e spesso ricorrono al tappo a vite anche per le loro bottiglie di maggior pregio.
Significa che il tappo a vite è migliore di quello in sughero? No, assolutamente: significa che le due tipologie di tappi hanno entrambe pro e contro. Sta al produttore scegliere la soluzione migliore per il suo vino.
Della serie: ad ogni vino la sua chiusura …
Tappo a vite: caratteristiche
Prima di addentrarci tra i vantaggi e gli svantaggi del tappo a vite (o Stelvin, dal nome del più importante produttore) analizziamo le sue caratteristiche.
Come puoi notare dall’immagine del nostro articolo, questa chiusura prevede un tappo metallico, con una filettatura a vite, ricoperto da una guaina in alluminio, che avvolge parte del collo della bottiglia, proteggendolo e conservandolo.
La loro particolarità sta però all’interno del tappo in metallo dove è presente un fondello di resina in cui è racchiusa una quantità minima di gas inerme che non interferisce con le proprietà del vino ma che al contrario contribuisce a preservarne le caratteristiche organolettiche.
Associato alla filettatura del collo della bottiglia, il tappo a vite garantisce estrema ermeticità. Quando però le bottiglie vengono aperte e chiuse troppe volte si corre il rischio che la filettatura si possa rovinare e la tenuta del tappo risentirne.
Tappo a vite e tappo in sughero: vantaggi e svantaggi
E ora entriamo nella disputa che sta dividendo gli addetti ai lavori: tappi a vite sì o tappi a vite no? Meglio il sughero?
Il dibattito è apertissimo e gli schieramenti ben definiti. Noi ci limiteremo a presentare i vantaggi e gli svantaggi di questo tappo, sempre convinti che “ad ogni vino la sua chiusura”.
Prenderemo in considerazione tutti gli aspetti fondamentali su cui il tappo a vite influisce e si differenzia da quello in sughero.
1. Conservazione e Invecchiamento
È la parola chiave, quella su cui si gioca gran parte di questo dibattito.
Il tappo a vite garantisce assoluta impermeabilità e impedisce all’ossigeno di filtrare e di entrare in contatto con la bevanda. Il tappo in sughero invece è leggermente poroso e lascia filtrare una minima quantità di ossigeno.
Sappiamo bene che i vini complessi e da invecchiamento richiedono un pò di ossigeno per completare la loro evoluzione in bottiglia, raggiungere la piena maturità ed esprimersi al meglio nel nostro bicchiere.
Tutto questo è possibile grazie al tappo in sughero mentre risulta difficoltoso con la chiusura Stelvin, anche se i produttori di tappi a vite stanno studiando nuove soluzioni per far fronte a questo problema.
Se invece il vino che il produttore mette in bottiglia ha già raggiunto il massimo della sua capacità evolutiva ed espressiva allora il tappo a vite è la soluzione ideale.
Il vino che si mette in una bottiglia con chiusura Stelvin resta tale, non subisce modifiche o cambiamenti.
Non è forse vero che: ad ogni vino la sua chiusura!
Da quanto abbiamo detto possiamo infatti affermare che i vini da invecchiamento, quelli che si prestano ad evolvere in bottiglia o quelli che il produttore vuole far continuare a maturare in bottiglia vanno chiusi preferibilmente con tappo in sughero.
Quelli giovani, già maturi o quelli che il produttore non vuole far evolvere perché considera al massimo delle loro potenzialità espressive vanno chiusi con il tappo a vite.
La nostra è una distinzione generale ma che fa capire che non esiste tappo migliore o peggiore. Esiste un tappo giusto per ogni vino.
Non è dunque un caso se in commercio troverete vini bianchi da bere freschi e giovani in bottiglie con tappo a vite e vini rossi che si prestano all’invecchiamento e all’evoluzione in bottiglia chiusi con tappo in sughero.
Ovviamente ci sono delle eccezioni ma questa è la tendenza generale.
2. Contaminazioni
La conservazione ideale di una bottiglia di vino con tappo in sughero prevede un contatto con il liquido.
In questo modo il sughero reagisce, rimane elastico e impedisce l’ingresso di una eccessiva quantità di ossigeno.
Allo stesso modo il vino rischia di essere influenzato da eventuali difetti presenti nel sughero e rischia anche di essere attaccato da quei funghi responsabili del famoso “odore di tappo”.
I tappi a vite, invece, sono inerti, non sono reattivi alle altre sostanze, non le modificano e a loro volta non vengono modificati. Ciò significa che l’eventuale contatto con il vino non comporta alcun cambiamento nella nostra sostanza.
Certo, in questo modo si perde l’ebbrezza dell’estrazione e della valutazione dei profumi del tappo per verificare la corretta conservazione ed evoluzione del vino ma evita spiacevoli sorprese sia per i produttori che per i consumatori.
3. Apertura
La facilità di utilizzo e la comodità di un tappo a vite è oggettivamente superiore rispetto a quella di un tappo in sughero.
Nessuno sforzo particolare, nessuno strumento necessario e nessun cavatappi: aprire una bottiglia con chiusura Stelvin è paragonabile all’apertura di una bottiglia di acqua.
Attenzione però, come abbiamo detto in precedenza, se le bottiglie vengono aperte e chiuse troppe volte si corre il rischio che la filettatura si possa rovinare, la tenuta del tappo risentirne con i conseguenti problemi di ossidazione.
Ma il vino non è acqua e il rituale dell’apertura di una bottiglia con tappo in sughero è qualcosa di romantico a cui è difficile rinunciare anche se le energie e il tempo richiesti sono superiori. Anche il tappo in sughero è riutilizzabile ma non garantisce l’ermeticità iniziale.
4. Sostenibilità
Infine, entrambe i materiali sono sostenibili.
I tappi sintetici possono essere riutilizzati per produrre nuovi tappi.
Il sughero, invece, è una sostanza naturalmente rinnovabile anche se va considerato un aspetto fondamentale: la quercia necessita di molti anni prima di poter essere lavorata e produrre sughero!
In tanti Paesi europei il tappo a vite è stato ormai sdoganato ed è utilizzato costantemente da molti produttori. In Italia non si può dire lo stesso.
Del resto siamo uno dei Paesi con la più longeva e ricca storia vinicola del mondo e siamo legatissimi alle nostre tradizioni.
Eppure qualcuno si sta muovendo nella direzione della chiusura sintetica senza per questo rinunciare al nostro amato sughero: dipende dal vino.
LA DURELLA
La Durella è un vitigno autoctono a bacca bianca diffuso in alcune aree collinari dei Monti Lessini, al confine fra le province di Verona e di Vicenza.
Le sue uve sono all’origine del vino Monti Lessini Durello DOC, declinato nelle quattro tipologie: Durello, Durello Superiore, Durello passito e Durello spumante.
Il vitigno era coltivato in piccola scala già dal 1700, conosciuto con il nome di Durasena fino alla prima metà del ‘900.
In questo periodo nacquero infatti diverse cantine che producevano il vitigno commercializzandolo in Europa e in piccole quantità in America.
Nel 2007 la fusione della cantina di Soave con quella di Montecchia di Crosara rilanciò il mercato del Durello in America e nei continenti extraeuropei.
LA GARGANEGA
La Garganega è un vitigno a bacca bianca. Il più importante delle province di Verona e Vicenza, la varietà che domina le colline della DOC Soave.
Non possiede una aromaticità spiccata, ma un piccolo patrimonio di profumi di cui la mandorla e i fiori bianchi sono i più nitidi.
La sua presenza abbraccia un largo territorio che parte dal Garda Veronese, non sono infatti rari i casi di ottimi bianchi ottenuti con questa varietà da produttori generalmente dediti al Bardolino, ed arriva fino alla fine dei Colli Berici, sconfinando nei padovani Colli Euganei (Torreglia, Galzignano Terme e Arquà Petrarca).
Nella Valpolicella Classica il suo utilizzo si è ristretto ad alcuni vini bianchi passiti, anche se molti contadini ottengono dalla garganega il vino bianco di tutti i giorni, talvolta venduto in damigiana.
In questo territorio, più vocato ai rossi, il vino bianco ha una visceralità e una forza rustica che lo distinguono dalle versioni più fini che cominciano a farsi vive dalla zona orientale della provincia di Verona.
Infatti già nella Valpolicella “allargata” (la zona non Classica), in particolare nei comuni di Mezzane e Illasi, la Garganega assume sfumature dalla mineralità più sottile, i delicati aspetti floreali del vitigno si avvertono e sostituiscono le sensazioni più “legnose” (quasi di corteccia) che appartengono ai territori occidentali e che ritroveremo in altre zone.
Nella zona del Soave non Classico, il vitigno veneto restituisce parte della sua lievità olfattiva e le aggiunge una quota di muscoli: il punto sta nel dosarne la naturale esuberanza produttiva evitando vini troppo diluiti ma anche prodotti troppo grossi che le farebbero perdere spontaneità.
Questa naturalezza sembra invece manifestarsi nei comuni di Soave e Monteforte, la zona del Soave classico: qui è la composizione del terreno, accanto alla consuetudine interpretativa, a fare la differenza ed abbiamo di conseguenza un’armonia leggiadra ed una continuità tra naso e bocca.
A Gambellara, appena entrati in provincia di Vicenza, la garganega, qui declinata al maschile e dunque garganego, offre l’altra sua versione più interessante e ricca di potenzialità.
Lungi dall’essere sottile e raffinata come nel Soave, acquista una mineralità più pronunciata e una struttura gustativa quasi tannica, al punto da rappresentare un bianco deciso dalle ambizioni gastronomiche completamente diverse da quelle del Soave.
Nel Vicentino troviamo ancora garganega nei Colli Berici, territorio dalle notevoli possibilità, e poi in qualsiasi vigneto della settentrionale area di Breganze è possibile reperire filari di questo vitigno raramente vinificato in purezza.
In provincia di Padova, ed in particolare nei Colli Euganei, ed in totale controtendenza con quello che il mercato farebbe intuire, vi sono alcuni produttori che stanno mettendo a punto bianchi a base di garganega ispirandosi proprio ai migliori esempi di Soave.
I MONTI LESSINI
I Monti Lessini sono un massiccio montuoso situato nella regione del Veneto, in Italia. Si trova nella provincia di Verona, a nord della città di Verona e a sud della Val d’Adige.
I Monti Lessini è una zona collinare che si estende per circa 30 km da nord a sud e per circa 20 km da est a ovest. Ha un’altitudine massima di circa 740 metri s.l.m. ed è caratterizzato da un clima fresco e ventilato, con temperature miti durante tutto l’anno.
La zona del Monte Lessini è famosa per la sua produzione di vino, in particolare il vino bianco denominato “Lessino”.
La vite è una delle principali colture della zona e il vino prodotto viene apprezzato in tutta Italia.
Oltre alla viticoltura, il Monte Lessini è anche una destinazione turistica per gli amanti della natura, con numerosi sentieri e percorsi escursionistici che attraversano le colline e i boschi del massiccio.
Ci sono anche diversi borghi storici e castelli che si possono visitare, come il Castello di Lavagno e il Castello di Roncà.

Rimani connesso al mondo MIA
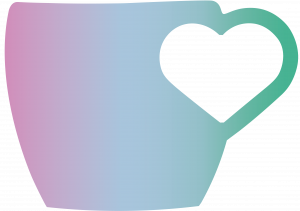
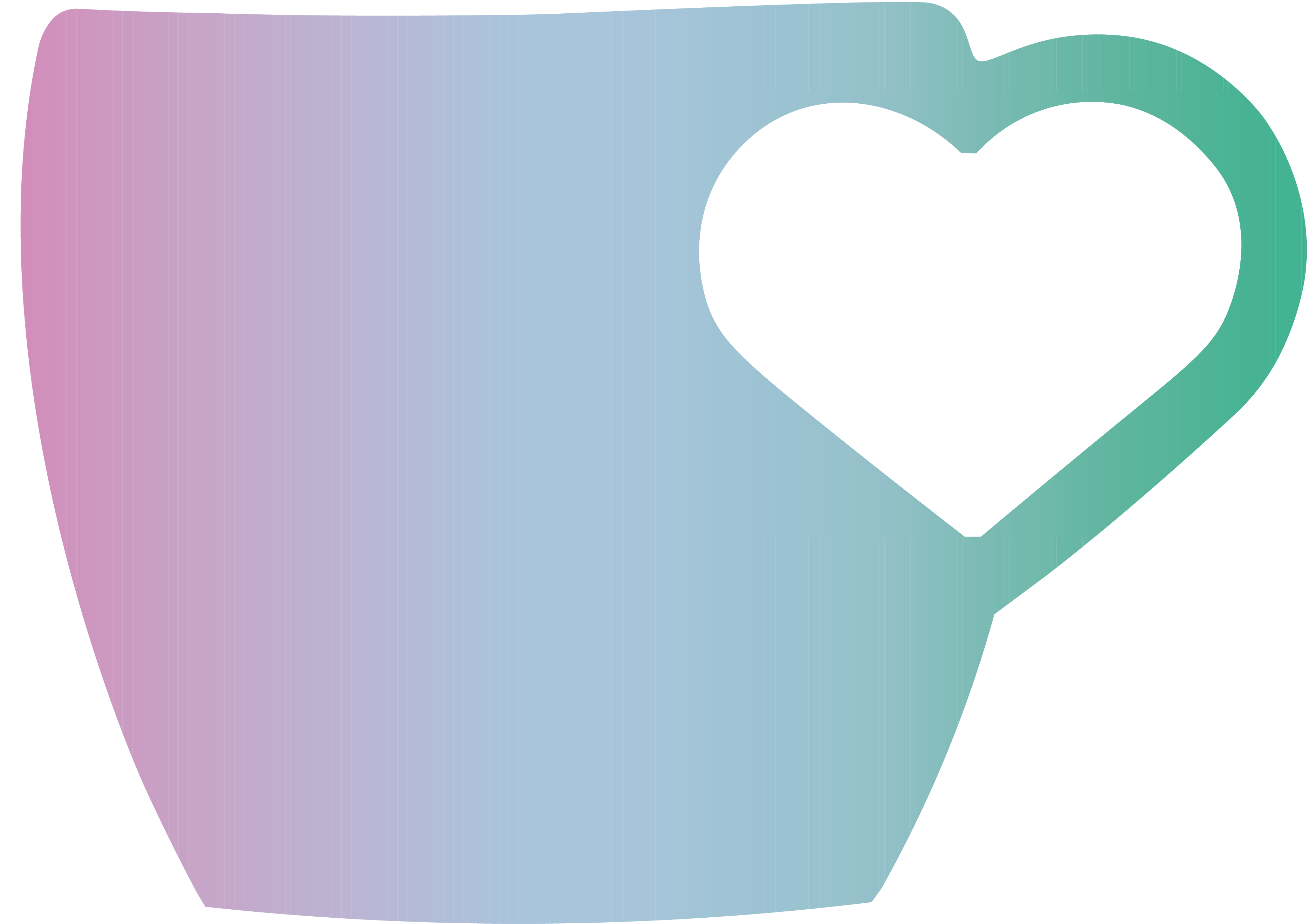




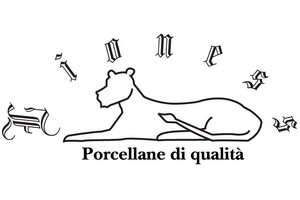


















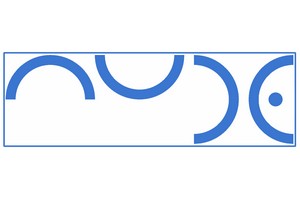
































































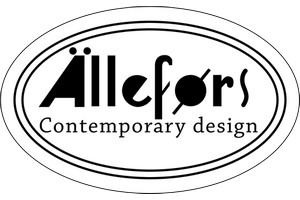



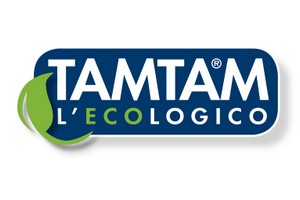









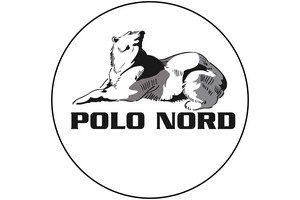













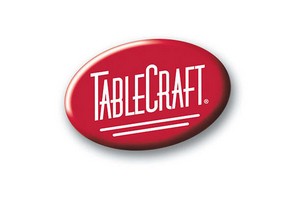







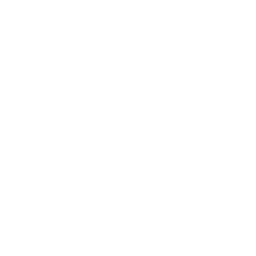

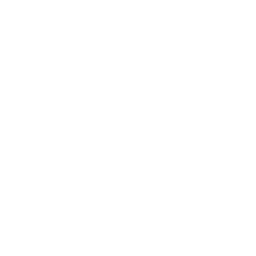


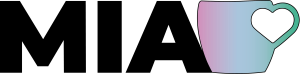
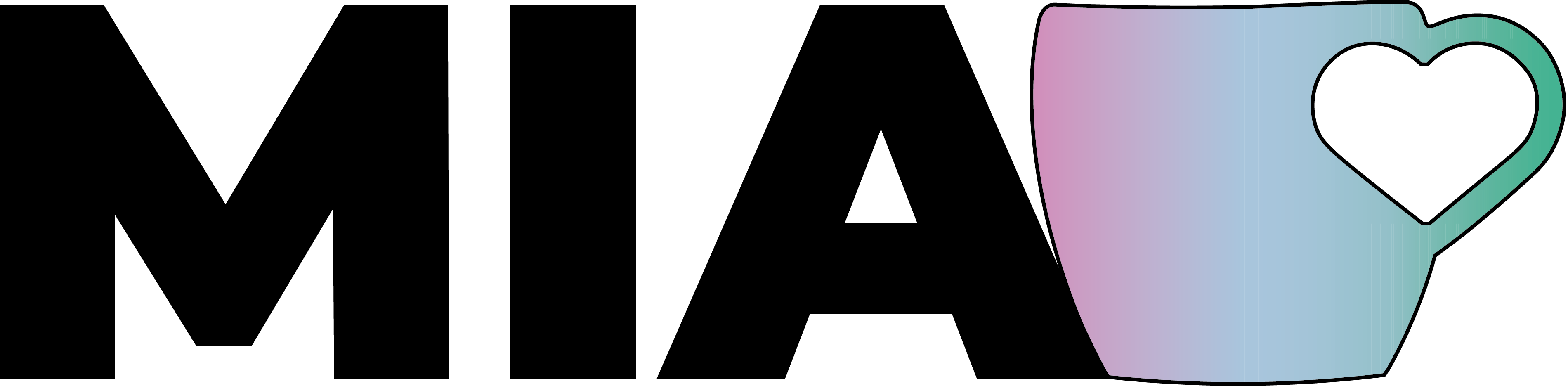
Recensioni
There are no reviews yet